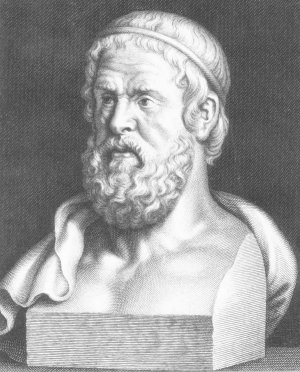
Il mondo antico conobbe la speranza nei termini in cui ora stiamo tracciandone il profilo (vedi articoli precedenti)? Mi sento di dire di no. Per prima cosa vorrei dire qualcosa sul mondo Greco. Esso fu fondamentalmente segnato dalla dimensione del Tragico (nella foto: Eschilo, tragediografo greco)
Con belle parole Salvatore Natoli – filosofo contemporaneo – osserva: “ La tragedia è qualcosa di più del semplice soffrire o della stessa esperienza della morte(…)essa è lo scontro con l’ineluttabile(…)l’essenza del tragico risiede nell’assolutezza del contrasto, essa si istituisce nella tensione fra opposte necessità… il tragico non è, però, relativo a eventi più o meno dolorosi, ma costituisce una dimensione ontologica”.
La vita dell’uomo antico conobbe certamente il piacere, la frenesia, la bellezza, l’entusiasmo, ma fu sempre sotto la spada pendente del fato, di un destino che annienta, contro il quale, l’uomo non può nulla. Egli sapeva che la sua vita è decisa dal destino, la morte era inscritta nella vicenda di ciascuno già al momento della nascita. L’elemento che maggiormente caratterizza la religiosità Greca è comunque la valorizzazione del presente.
Come attesta il grande storico delle religioni Mircea Eliade: “ la gioia di vivere scoperta dai greci non è un godimento di tipo profano, rivela la beatitudine di esistere, di partecipare alla spontaneità della vita e alla grandiosità del mondo. Come tanti altri, prima e dopo di loro, i Greci hanno appreso che il mezzo più sicuro di sfuggire al tempo è quello di sfruttare fino in fondo la ricchezza dell’attimo fuggente.”
Il nostro tempo, anche in questo, sembra riproporre un ottimismo vitale legato alla possibilità della longevità e della pienezza di ogni attimo secondo la logica del carpe diem. In questa prospettiva si inscrive l’emergere prepotente di un vero e proprio culto del presente e dell’autoaffermazione a scapito dell’altro. L’individualismo contemporaneo germina e prolifera infatti dentro la dimensione competitiva del nostro tempo. Gli uomini, la cui unica speranza, il cui unico ottimismo, si situa nella riuscita in tempi brevi dei propri progetti, necessariamente vedranno nel prossimo non un fratello, ma un potenziale avversario.
Non a caso i movimenti più aggressivi e “progressisti” che calcano la scena della politica contemporanea, insistono per affermare sempre più i diritti individuali a scapito della dimensione comunitaria. Ma torniamo alla religione greca: per i contemporanei di Omero, la morte consisteva in una forma di esistenza umbratile, larvale, priva di consistenza. Lo spirito di Achille evocato da Ulisse dichiarerà preferibile una vita da schiavo sulla terra piuttosto che una da sovrano nel regno dei morti. E fu così anche per l’uomo romano, che proprio in ragione di un bisogno insopprimibile d’eterno e perciò di senso, si lasciò sedurre dal fascino del cristianesimo. Perché l’uomo antico, come abbiamo visto appare segnato dalla sconfitta e la vita per quanto lunga muove verso un destino d’oblio e di dissoluzione. E poco consola l’idea che da tale contrasto, da tale distruzione, germinerà nuova vita; o che attraverso le virtù di una vita secondo natura-come insegnava lo stoicismo-si potesse pacificare il dissidio che era in ciascuno. Sul fondo di queste concezioni è presente un’idea pessimistica dell’esistenza, vinta e in qualche modo occultata dalla forte carica comunitaria e religiosa, densa di simbolismi e riti che rendeva il quotidiano accettabile e dotato di senso.
Questa dimensione è -tra l’altro- esattamente ciò che manca nel modo più assoluto alla civiltà occidentale secolarizzata. Ma il mondo greco ad un certo punto incontrò un’altra tradizione L’Ebraico-Cristiana. Osserva ancora George Weigel, nel suo bel libro “La cattedrale e il Cubo: “Nel mondo classico, così come nel mondo pagano del Mediterraneo orientale abitato da ebrei, come ricordato nella bibbia ebraica, gli dei o il Fato giocavano con uomini e donne, spesso con conseguenze letali; si ricordi per esempio l’interferenza degli dei nelle vicende umane dell’’Iliade e dell’ Odissea(…)L’apparizione nella storia di un Dio unico chè non era né un tiranno ostinato né un’astrazione lontana, fu percepita come una grande liberazione(…)La storia non era infatti un palcoscenico in cui gli esseri umani erano manovrati dagli dei e dalle divinità come burattini; la storia era piuttosto un’arena di responsabilità e di propositi.”
E’ a questo livello che può emergere la speranza, cioè nel momento in cui l’uomo può sentirsi protagonista di un destino, seppur legandosi liberamente in un rapporto con Dio che, come vedremo, diviene sorgente di libertà vera e di fondata speranza. E’ a partire da questa idea di vita e di storia che prenderà corpo dentro la teologia cristiana il coraggio di pensare l’intera vicenda umana come espressione di un piano divino carico di attenzione verso l’uomo e perciò portatore di una speranza che vince ogni timore.
La speranza nell’antico testamento.
A differenza degli altri popoli il popolo di Israele ha preso forma ed ha vissuto con una costante apertura verso il futuro. Esso ha sperimentato la speranza come elemento costitutivo della propria storia. Rispetto a tutti gli altri popoli il popolo ebraico ha concepito il tempo non più secondo una prospettiva circolare, bensì lineare. Il tempo per il pio israelita ha avuto un inizio e muove verso una fine, che ne realizza il senso e la pienezza. Eppure anche la storia del popolo ebraico mosse da un singolo interpellato, chiamato ad una nuova vita da Dio stesso. La vicenda di Abramo, in tal senso, fonda il cammino di Israele. Dio conosce, promette, provoca una speranza. Essa, per il padre della fede ebraica è individuata nella possibilità di una discendenza. In tal modo la vita del singolo appare riscattata dal pericolo dell’oblio. Abramo infatti non conosce e perciò non crede nella vita eterna.
Egli però crede nella promessa di Dio a tal punto da essere disposto a sacrificare la cosa che più ama, il figlio Isacco. Abramo credette contro ogni speranza, nella disperazione più nera; nel silenzio stesso di Dio egli ebbe il coraggio di dire sì, di rispondere ancora alla chiamata. Perciò la sua speranza non fu tradita. Emerge in tal modo con chiarezza un primo vincolo, quello che lega strettamente speranza e fede. La speranza di Abramo assume nella tradizione ebraica il volto di un’ attesa storica, di un riscatto del mondo dalla malasorte, grazie all’intervento di Dio, un Dio che non è più numen locale ma personale. Vorrei soffermarmi con una certa attenzione sull’episodio che forse più di ogni altro rivela la speranza del credente Ebreo: la storia di Isacco. Tutti sappiamo come Abramo visse e sperò. Egli, udita la voce di un Dio personale, lasciò le certezze del suo mondo, della sua città, dei rassicuranti riti offerti alle divinità caldee e si mise in viaggio. La speranza di avere un figlio si realizzò per lui quando sua moglie Sara era oramai vecchia.
Quel figlio crebbe e quando fu forte, un ragazzo nel cui sguardo Abramo poteva ora riconoscere se stesso, Dio gli comandò di salire sul monte Moira, per offrire un sacrificio. Mentre saliva sul monte certamente Isacco fu consapevole che mancava l’oggetto del sacrificio; si inquietò, non comprese, forse ebbe paura, ma si fidò di suo padre. E quando lo interpellò con la domanda che oramai in lui urge incessantemente, ricevette dal padre questa risposta: “ Dio provvederà…”( Gn.22,8). L’ansia, nel cuore di Isacco crebbe mentre lo spettro della disperazione si faceva strada nella granitica fede di suo padre. Giunti sul monte, con gesti lenti ed esperti prepararono l’altare, insieme; poi, credo, Isacco si dispose sul’ara e porse le mani e le caviglie al padre perché le legasse. Fra i due non ci furono parole, non credo, tutto accadde come si stesse svolgendo un tragico copione, come se l’antico e pagano Fato fosse riapparso a riscuotere il conto, e la colpa accumulata da quel temerario vecchio e dal suo sciagurato figlio. Ma quando il coltello si alzò e tutto sembrò perduto -il tempo, la promessa, l’attesa, il senso della nascita, della vita- Abramo ed Isacco simultaneamente videro un montone impigliato con le corna nella sterpaglia.
Osserva il nostro Papa BenedettoXVI: “Tutto il culto proviene da questo sguardo di Isacco, da ciò che egli ha visto in quel punto(…) In questo attimo è diventato evidente che la storia universale non è una tragedia, non è un irrisolvibile dramma di potenze in lotta tra loro, ma divina commedia: colui che aveva gettato uno sguardo sulla realtà ultima -la morte- poteva ridere.”
Se ci pensiamo, Isacco conosce sino in fondo il patire; ma in questo caso, il dolore ed ogni sofferenza, a ben vedere, non coincidono con l’attimo della morte, bensì con tutto ciò che precede questo istante. Isacco conobbe tutta l’angoscia e il non senso che precede la morte; in più, egli conobbe l’apparente abbandono di Dio. Egli, salendo al monte, ebbe modo di maturare la disperazione, di sentirla crescere dentro. Ma nell’attimo del morire per mano di chi gli aveva dato la vita, egli vide il montone e tutta la sua sofferenza assunse un valore: Dio provvede. Lasciamo, per ora, questa straordinaria storia per riprenderla fra un po’ ed assaporarne così il gusto pieno. Per fare questo dovremo però attendere la definitiva rivelazione, quella di Cristo. Torniamo, per ora alla speranza di Israele. Attraverso la storia di Abramo, dunque, si affaccia nel cuore dell’ebraismo la speranza; ma essa si precisa ulteriormente con la vicenda storica di Mosè. Anche lui fu provato, ma nonostante le molteplici prove egli si erse davanti al suo popolo come il liberatore. Con lui nella coscienza di Israele maturò l’idea di un Dio liberatore, di un Dio vincitore, di un Dio legislatore. Mosè sperò: quando mosso da pietà nei confronti del proprio popolo oppresso dal faraone cercò di liberarlo. Ma egli fallì, perché non comprese che solo affidandosi a Dio lo sforzo umano non risulta vano. Ci volle l’esperienza del deserto e l’abbandono della propria presunzione e la spogliazione di sé, perché, dopo l’epifania del roveto ardente, Mosè diventasse il condottiero, il “liberatore”.
Ma Mosè non entrò nella terra promessa; egli però insegnò al suo popolo come si può vedere Dio: “Seguire Dio, dovunque Egli ci porta, proprio questo significa vedere Dio”( Gregorio di Nissa.). L’esperienza di Abramo si ripropone dunque con Mosè; il seguire Dio, con lui però si connota di una nuova dimensione: quella morale. Questo significa che l’agire per conseguire la pienezza del bene cui ciascuno aspira, non può fare a meno del dono della legge di Dio. In tal senso la legge morale espressa nelle tavole che Dio consegna a Mosè, appare come fonte unica di liberazione, come la sola e vera via che affranchi l’uomo da ogni presunzione di autosufficienza. La legge morale appare dunque come l’insopprimibile base sulla quale scommettere la vita dentro una prospettiva di fondata speranza.
Ma la storia di Israele è storia di tradimenti. Ben presto, il regno di Dio assunse una valenza politica, troppo umana, poco attenta alla reale volontà del creatore, inoltre il primato della morale finì per moltiplicare la dimensione precettistica che pesò sempre più sulle spalle dei fedeli. Contro questo modo di concepire l’Alleanza con Dio, un modo che sembra volere possedere il futuro attraverso una costruzione umana, reagì la critica profetica. Il profetismo biblico sviluppò l’attesa messianica su una linea di profonda interiorizzazione dei valori. In tal senso l’uomo appare come la causa del male e questo per la sua incapacità di corrispondere al volere di Dio, al suo appello. L’esilio è letto dai profeti come il castigo attraverso il quale Dio converte, purifica, rende sapiente il popolo, che attende un’azione futura di Dio capace di liberarlo dai propri idoli.
Con la letteratura del tardo giudaismo e con la letteratura Apocalittica emergono due nuovi elementi. Si intravvede, come radice della speranza, in primis, la possibilità della resurrezione, ovvero di un Dio che vince la morte, ripianando le ingiustizie e dando a ciascuno la propria mercede. Il libro dei Maccabei si caratterizza in particolare per questo annuncio, in un conteso globale in cui molti movimenti messianici avevano conosciuto l’onta della disfatta. Secondariamente emerge la convinzione che l’intera vicenda umana riveli progressivamente il piano salvifico di Dio, anzi che la storia sia proprio una storia di salvezza e perciò meritevole di speranza totale. E’ questo il senso della letteratura apocalittica ossia della rivelazione di ciò che era nascosto.